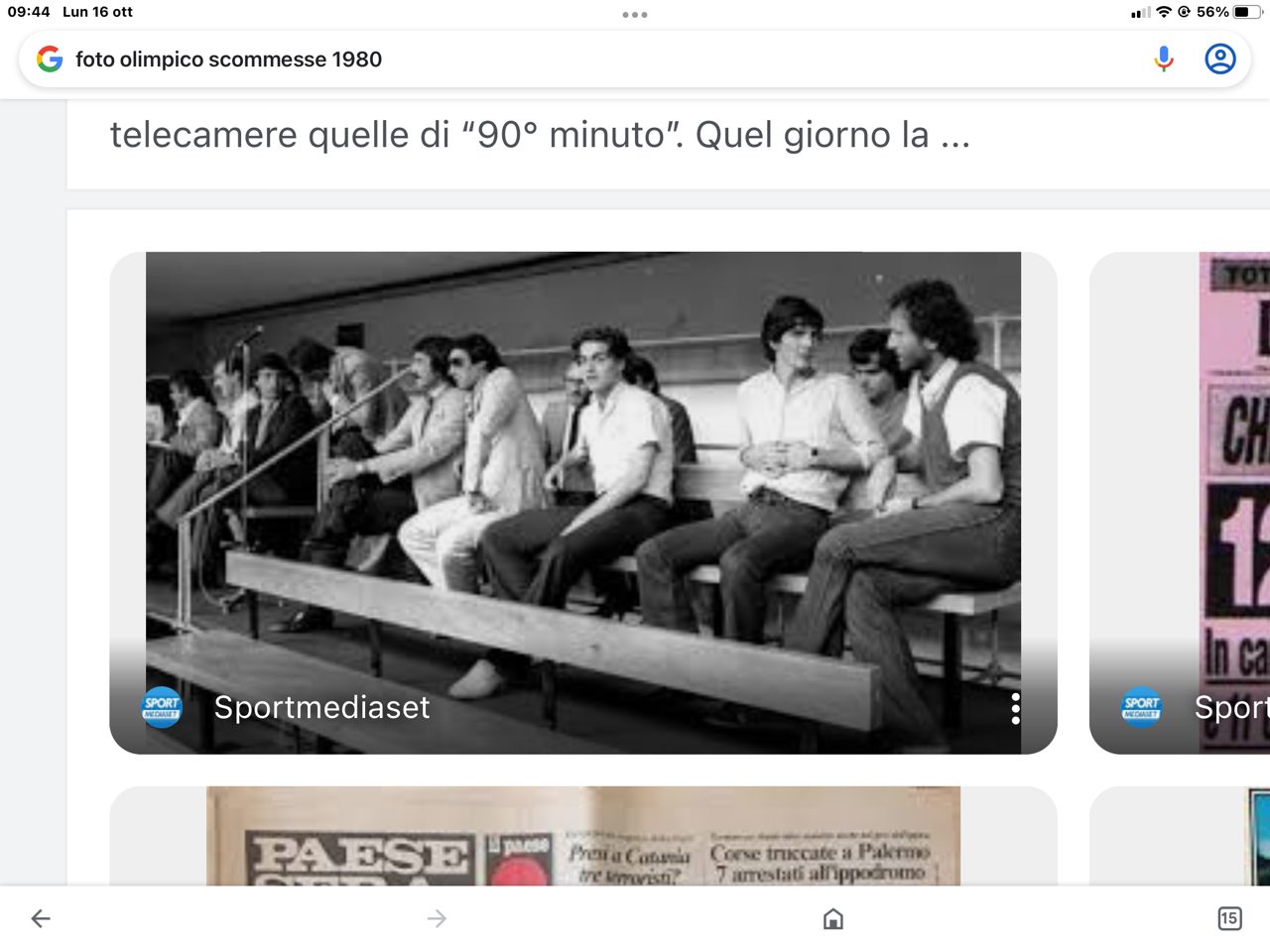Di Michelangelo Russo
L’antica tradizione dell’avvocatura voleva che l’avvocato di prestigio mostrasse, nei modi e nell’aspetto, un’eleganza sobria che fosse segno di deferenza al Giudice, sia in aula, sia al cospetto del magistrato.
Dario Incutti, dalla prima volta che lo incontrai tantissimi anni fa, non venne mai meno a questa regola essenziale dei rapporti, a volte tesi e giammai aspri, che si instaurano tra i fronti opposti dell’accusa e della difesa. Già il cognome che portava incuteva rispetto a chi, come me, era stato alunno del Liceo Tasso quando suo padre ne era stato l’inflessibile Preside. Il figlio Dario pareva indossare, più che la toga di parte dell’avvocato, quella neutrale del docente; credo che ne fosse consapevole, perché il discorso con lui non scadeva mai nel confidenziale, rimanendo come distillato nell’illustrazione dell’essenziale. Si fermava ai dati di fatto e di diritto. L’umanità dell’imputato non veniva mai usata come argomento di “captatio benevolentiae”, espediente sovente usato dai difensori per ammorbidire, per quanto possibile, la durezza del Pubblico Ministero. L’aspetto dell’avvocato gentiluomo era accentuato da quel cappello blu a tesa larga che prontamente si toglieva prima di varcare la porta dei nostri uffici in Procura, chiedendo il permesso di poggiarlo sulla scrivania se non c’era una sedia libera. La ritualità dei suoi gesti era in riga con lo scopo della visita, e faceva intendere al magistrato, subito, che il difensore non era venuto a far perdere tempo all’inquirente, ma a puntualizzare l’urgenza di una decisione. Visite brevi in ufficio, e arringhe essenziali in aula senza colpi di scena, ma temibili per il rappresentante dell’Accusa. Era sempre così. Dario Incutti trovava sempre nelle carte del processo quel rigo che il Pubblico Ministero sperava che non trovasse mai il difensore. Perché era quell’ombra incerta, data per superflua nella visione accusatoria, che Dario Incutti era capace di dilatare, con l’eloquio forbito e formale, fino alla dimensione del dubbio, che è un territorio micidiale per ogni Tribunale.
Che si alimenta di certezze non discutibili per emettere sentenze. L’arte dei principi del Foro di una volta era questa: la parola, la voce viva del retore, con la lingua italiana ineccepibile e senza accento usata come arma tagliente per vivisezionare l’apparente logica della prova scritta. I grandi nomi degli avvocati del secolo scorso meriterebbero una iscrizione lapidea sui muri anonimi di questo nuovo, insipido Tribunale. L’Ordine degli Avvocati dovrebbe pretendere una iscrizione del genere. Servirebbe quantomeno a ricordare alle nuove generazioni un tempo in cui la voce faceva il processo, e non la comunicazione telematica. Non è un rammarico passatista: qualcuno deve iniziare a ricordare a tutti che nei Tribunali si giudicano persone vere, esseri umani con i loro drammi, e non scartoffie uscite da una stampante. Ma Incutti non era solo l’avvocato con la toga. Aveva un istinto innato per la teatralità: la considerava un aspetto naturale della professione, ma non nel senso deteriore della spettacolarità enfatica dell’eloquenza, ma come stimolo delle capacità immaginative dell’ascoltatore. Perché il magistrato deve immaginare l’azione su cui si appunta il suo giudizio: immaginare la realtà accaduta, non fantasticare, si badi! E così lo ricordo in una memorabile serata al Circolo Sociale, nei primi anni ’90. Incutti recitò davanti a pubblico attento. Ma attenzione! Più che recitare, disegnò con la voce una strada di Parigi, e un suo incontro straordinario e misterioso che aveva avuto qualche anno prima. Mise in testa il cappello blu, e la mimica che mai avrebbe usato in Tribunale illustrò il fondale di un palcoscenico che non aveva immagini, se non quelle suscitate da una voce magistralmente modulata sulle emozioni. L’applauso finale di quella serata lo accompagni in questo suo ultimo viaggio.