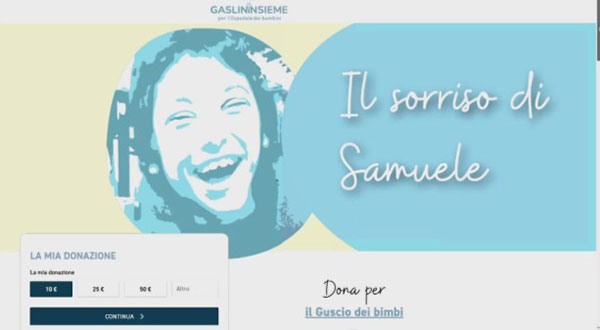di Peppe Rinaldi
Esiste una patologia del diritto che trasforma le aule di giustizia in labirinti senza uscita, dove il dolore delle vittime, un certo tipo di vittime almeno, rischia di diventare un freddo dettaglio procedurale. Il caso degli abusi sui bambini presso la scuola materna “Paolo VI” di Vallo della Lucania è, in tal senso, un paradigma tragico. A vent’anni dall’inizio dei fatti la Corte di cassazione civile ha dovuto alzare nuovamente la voce, annullando la sentenza della Corte d’appello di Salerno e disponendo un nuovo giudizio. È l’ennesimo atto di una tragedia che non conosce il sipario, dove il tempo non è stato galantuomo ma complice dell’oblio.
Un excursus tra orrore e burocrazia
La genesi del dramma risale al maggio 2006. In quel contesto, quella che doveva essere un’oasi educativa e formativa si trasformò in un luogo di violenza per alcuni bambini. La religiosa Carmen Soledad Bazan Verde finì in custodia cautelare con l’accusa di abusi sessuali su bambini di appena cinque anni. Ad arrestarla fu il procuratore della repubblica del tempo Alfredo Greco. Il primo grado di giudizio, conclusosi nel 2012 a Vallo della Lucania, produsse una sentenza di roccia: 8 anni alla Bazan e condanne per favoreggiamento alla direttrice e alla vicedirettrice, colpevoli, secondo i giudici, di aver alzato un muro di silenzio attorno a quegli orrori. Non è il primo caso, non sarà l’ultimo all’interno di una scuola, di una parrocchia, di un centro sportivo o in un’abitazione privata: certo non è prerogativa «cattolica» questa infame pratica (quando è accertata per davvero) nonostante la vulgata converga, ingiustamente, su questa linea di pensiero comune. Ma questa è un’altra storia.
Torniamo al fatto centrale perché il percorso verso la giustizia è stato minato da quello che appare come un incredibile cortocircuito tra uffici giudiziari. Se il tribunale di Vallo aveva scavato nei fatti con precisione chirurgica, la fase d’appello a Salerno ha rappresentato una frattura inspiegabile, in un certo senso. Nel 2016, la Corte d’appello penale ribaltò tutto, mandando assolte le suore. Un esito favorito da un atteggiamento della Procura generale del tempo che ha lasciato interdetti molti osservatori: dopo aver sostenuto l’accusa per anni, la Pg chiese sorprendentemente l’assoluzione finale (addirittura sostenendo per tabulas la presenza di allegati agli atti in realtà mai esistiti!) sigillando di fatto il destino penale della vicenda con un giudicato che oggi appare inamovibile.
La scure della Cassazione: “Sotto il minimo costituzionale”
Oggi la partita si gioca solo sul terreno civile, l’unico rimasto aperto per ottenere un riconoscimento che sa di beffa, vista l’età ormai adulta delle vittime. Ma anche qui, la Corte d’appello di Salerno ha inciampato. La Suprema Corte, infatti, nella sua ultima motivazione (luglio 2025) non ha usato mezzi termini definendo il ragionamento dei giudici salernitani come “irrimediabilmente lacunoso e internamente contraddittorio”. Il linguaggio dei giudici di legittimità è quasi brutale: la sentenza di Salerno è stata giudicata “solo apparentemente motivata”, situandosi “al di sotto del cd. minimo costituzionale”. In altre parole, la magistratura di secondo grado avrebbe ignorato i criteri logici elementari per inseguire una tesi assolutoria priva di coerenza con le prove raccolte. Un bordello, si direbbe oggi sfiorando un sarcasmo forse inopportuno tenuto conto del contesto e dei luoghi dei fatti. È, tuttavia, la conferma di una resistenza incomprensibile nel riconoscere una verità che, se ammessa, metterebbe a nudo le gravi responsabilità di chi avrebbe dovuto vigilare e non l’ha fatto.
La dittatura del tempo: la giustizia come relativismo
Qui si innesta una riflessione necessaria sulla lentezza dei processi in Italia, un male endemico che finisce per alimentare una sorta di relativismo che svuota di significato ogni valore oggettivo. Se la giustizia ha bisogno di due decenni per stabilire se un bambino sia stato violato, la sentenza finale smette di essere un atto riparatorio e diventa un documento archeologico. In Italia, la durata media di un processo che attraversa tre gradi di giudizio è tra le più alte d’Europa, un paradigma che sa ormai di stantio a furia di ripeterlo: e ieri se ne è avuta la miliardesima conferma con il rituale florilegio di lamentazioni da parte delle figure dell’apparato che vi dovrebbe porre rimedio. Anche questo è un grande classico.
Nel caso del “Paolo VI”, siamo arrivati a venti anni di attesa. Questo tempo dilatato permette alla verità processuale di divergere dalla verità reale. Il tempo trasforma il diritto in un’opinione variabile, dove il consolidamento di errori procedurali impedisce di arrivare a una conclusione giusta. È la vittoria del formalismo sul valore della persona umana. Quando il giudicato penale si cristallizza su un’assoluzione per inerzia degli uffici inquirenti, lo Stato abdica alla sua funzione regolatrice. “La giustizia che non è celere non è giustizia: è solo un’ingiustizia più lenta”, lo disse secoli fa un certo Seneca, epicureo quanto basta per fotografare ciò che avviene ancora oggi e, chissà, forse avverrà ancora domani.
Nel caso dei minori di Vallo, il riconoscimento della verità, arrivando dopo vent’anni, è ormai privo della sua forza catartica, liberatoria. Le vittime sono cresciute nell’ombra di un sospetto mai del tutto dissipato dalle aule di giustizia, nonostante i ripetuti richiami della Cassazione.
Il ruolo della Chiesa e la coscienza delle istituzioni
Mentre la magistratura si avvita su se stessa, un raggio di luce giunge paradossalmente dall’istituzione che era stata lo scenario del dramma: la Chiesa. Il cambio al vertice della diocesi ha portato un nuovo vescovo che, rompendo con il passato, ha cercato il dialogo con le famiglie delle vittime. Un atto di vicinanza morale che gioca un suo ruolo specifico in questa avvilente faccenda.
Resta infatti il dubbio etico, chiamiamolo così: come possono gli uffici giudiziari ignorare le lacune segnalate per ben due volte dalla Cassazione (una volta in sede penale e una in sede civile)? L’inerzia di chi avrebbe dovuto proteggere i diritti dei minori rischia di restare una macchia indelebile. È la dimostrazione che, quando le istituzioni rinunciano alla ricerca della verità per «amore» di una stasi burocratica, aprono la strada a quella dittatura del caso dove a vincere non è chi ha ragione, ma chi riesce a far passare più tempo. Il nuovo rinvio alla Corte d’appello di Salerno rappresenta l’ennesima chiamata alla dignità del sistema giudiziario, in questo caso campano. I legali delle vittime hanno già avviato le procedure di riassunzione. Non si tratta più solo di quantificare un danno economico, ma di restituire un briciolo di fede nello Stato a un intero territorio.