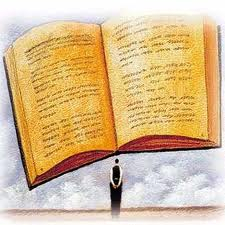L’ultima opera di Puccini, condotta avanti con fatica in un clima di perenne incertezza e di sfiducia, testimonia una fase di dolorosa crisi creativa in cui era giunta allo spasimo la famosa “ricerca del libretto”, suo perenne tormento dopo ch’ebbe perduto la provvidenziale coppia Illica e Giacosa. Nell’assenza di reale contenuto drammatico, quale avrebbe dovuto essere la trasformazione della “principessa di ghiaccio” in donna innamorata (“Tu dei baci già senti l’aroma, Tu sei doma, sei tutta languor!”), il color locale, elemento collaterale di cui Puccini si era sempre giovato con abilità, divenne l’alfa e l’omega dell’opera, inzuppandola in un insopportabile orientalismo da bazar: esotismo domestico da carillon, trovato alla buona sui tasti neri del pianoforte. Tutto ciò non riguarda, ben inteso, la parte di Liù, la quale sta lì come pietra del paragone per mostrare che cosa era Puccini. Negli altri personaggi, con qualche rara e benvenuta eccezione per il principe Calaf, il fiore della melodia si estingue, vuoi perché esaurito dalla condizione fisica del compositore, già crudelmente attanagliato dal male che l’avrebbe stroncato nella clinica di Bruxelles, vuoi per un’infelice convinzione che bisognasse scrivere dei drammi musicali alla maniera di Pizzetti per sembrare “moderno”. Ne viene all’opera, pur con tutto il suo sfarzo esteriore, un lugubre gelo, una freddezza intima che la fa parere l’elaborato scrupoloso d’un Cherubini del ventesimo secolo e le conquista la stima non lusinghiera d’un veteroclassicismo, non riscattato dalla scintilla dell’ironia. Quanto all’entusiasmo popolare che l’opera continua a destare e che – diciamo subito – ha raggiunto vette eccezionali qui a Salerno, con il teatro Verdi tutto esaurito per la prima di Martedì sera, esso è scatenato inizialmente dalla grandiosità dello spettacolo e dalla magniloquenza sonora della scena iniziale, dove affiora l’Inno a Roma tradotto in cinese. Poi si alimenta delle poche briciole di melodia affidate a Calaf e Liù, e della tensione drammatica della scena degli enigmi, dove Puccini rinnova l’abile suspense della partita a carte di Minnie con Jack Rance. Il cattivo gusto, massimo comun denominatore della democrazia artistica, tocca il culmine nello spaventoso bric-à-brac esotico del trio Ping-Pong-Pang, dove le infauste maschere della commedia dell’arte, di erudita e accademica memoria, si camuffano da bonzi cinesi, essendo il “pittoresco” il dichiarato traguardo prefissosi dai librettisti ed imposto all’innocente compositore. Il quale, in mancanza di genuine invenzioni per quei tre ridicoli fantocci, non trova di meglio che affidargli il lirismo smanceroso della Frugola del “Tabarro” (“Ho una casa nell’Honan”, “Ho sognato una casetta”).
L’esecuzione salernitana è stata sorprendente, in particolare sotto l’aspetto scenico, che ha portato non poche difficoltà per un palcoscenico così ridotto. Riccardo Canessa ha fatto un ottimo lavoro, come è suo solito, unitamente allo scenografo Flavio Arbetti, con un gioco di piani, per riuscire a sfruttare ogni tavola, e fondali, rivisitando certe japonaiserie dell’epoca, con un interessante gioco di luci che ha portato dal moonlight di morte del primo atto, alla notte di attesa in funereo viola con gioco di lanterne, sino al trionfo finale, senza mai cadere nell’eccesso, quando i due “puri”, possono finalmente ascendere quali novelli imperatori al Cielo, avendo superato le prove, riuscendo a rendere la magnificenza della reggia e gli umori del popolo, con pochissimi movimenti. Il direttore Daniel Oren, dividendosi tra la Bohème parigina e la nostra Turandot, ha offerto una lettura molto controllata dell’opera, cercando di portare a termine senza grandi defaillance lo spettacolo, guidando una Filarmonica “Giuseppe Verdi”, senza esperti rinforzi esterni e con diversi giovani che fanno quel che possono, sciogliendosi solo nel finale quando posata la bacchetta ha addirittura battuto le mani a guisa di piatti. L’esecuzione è andata quasi del tutto liscia, al di là di qualche black out in buca proprio nella prima parte del Nessun dorma!, urti tra ottavino e primo oboe, qualche anticipo di percussioni, in un senso di supremo equilibrio, posto in bilico da qualche indecisione dell’intonazione sia delle voci bianche, sia del coro che, in complesso ha offerto una sufficiente prova, grazie all’impegno profuso dal nuovo e giovanissimo direttore Francesco Aliberti, il quale è cresciuto proprio nel nostro conservatorio, nel nostro massimo e non ultimo nel nostro ateneo e che dopo numerose esperienze in diversi teatri italiani, vi ritorna da preparato titolare a soli 31 anni. Una forza giovane la sua che deve essere d’incoraggiamento per svecchiare con decisione e per intero, in tutti i ruoli, le masse artistiche del teatro Verdi di Salerno. Sul cast dei cantanti ha regnato incontrastata la voce di Alida Berti, una perfetta Liù. Il filo pauroso della sua voce e dei suoi filati è giunto sino a noi distinto e singolarmente commosso da una lontananza che strazia, supportata da una recitazione fragile e stupita. Lise Lindstrom ha tutto quel che ci vuole per l’ingrato personaggio di Turandot: la grinta, la voce d’acciaio e la presenza altera, senza, però, nemmeno un momento di morbido abbandono. Deludente il Calaf di Vladimir Galouzine, tenore potente ma sciatto nella pronuncia e appesantito nell’emissione, forse stanco per il viaggio diretto Vladivostok-Salerno per la prima, il quale ha comunque strappato gli applausi a scena aperta, per l’attesissimo “Nessun dorma!”. Un Timur di buone risorse vocali si è rivelato Paolo Battaglia, così come anche Ping, Pong e Pang cui hanno prestato le voci, Fabio Previati, Francesco Pittari e Domenico Menini, molto graditi al pubblico.
Pubblico entusiasta e tre “chiamate” al proscenio per l’intero cast.
Olga Chieffi