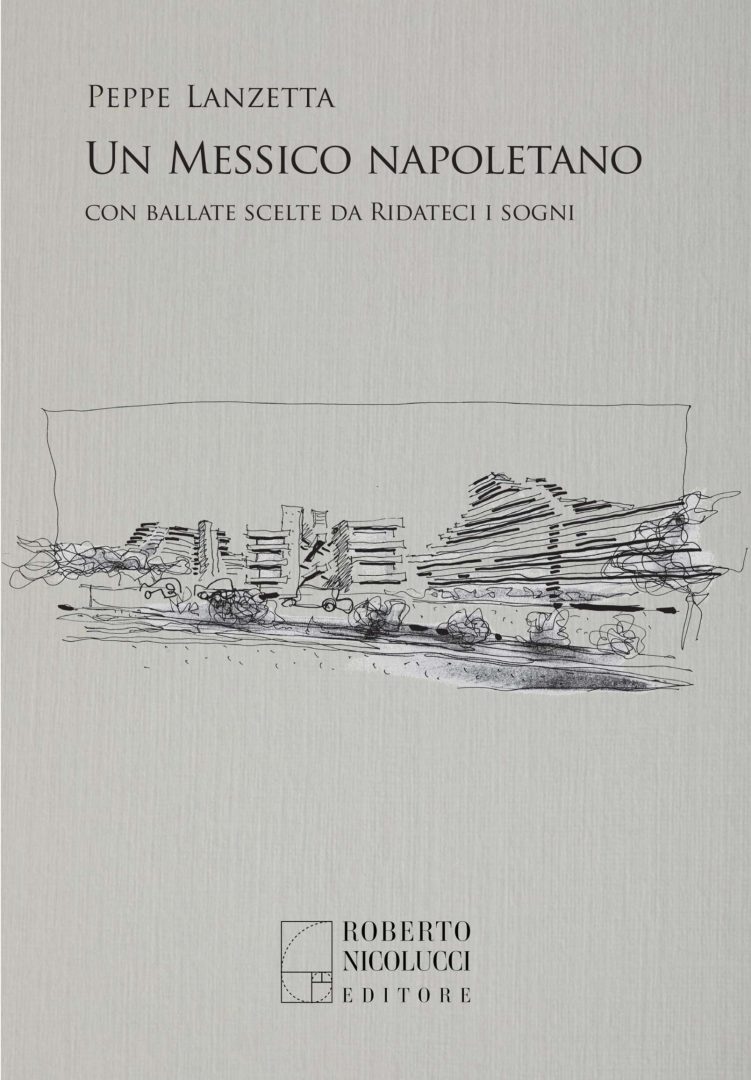di Barbara Ruggiero
Bellezza, disperazione e autenticità. Sono le tre parole chiave con cui Paolo Sorrentino presenta la riedizione di Un Messico napoletano, libro che torna in ristampa dopo trenta anni dalla prima pubblicazione. Bellezza, disperazione e autenticità: tre ingredienti che Lanzetta mescola sapientemente per raccontare la storia di Anna, la Rossa, una diciannovenne che si muove nei quartieri più infimi della città di Napoli, che cerca il riscatto in un amore malato per Marco, che si muove tra rabbia, odio, indifferenza, e che finirà tragicamente. L’urlo di una generazione ma «non solo un racconto di periferia» – dice Lanzetta.
Un Messico napoletano torna in ristampa dopo circa 30 anni dalla prima pubblicazione: ma allora questo testo è immortale?
Sono giusto trent’anni, anzi forse qualcosa in più: la prima stesura risale al 1992. Potremmo dire che questa storia mi è sopravvissuta. Negli anni, nel riferirsi a questo libro oppure a Figli di un Bronx minore, mi dicevano che io raccontavo una Napoli di là da venire, dark, nera, dove pioveva sempre o magari in cui c’era solo un sole messicano. Ho dovuto aspettare il disgelo, ho atteso che passasse l’onda del Neapolitan Power, del gomorrismo, per riprendermi quello che era stato un urlo generazionale.
Da dove nasce la voglia di raccontare una Napoli dark, per riprendere la sua definizione?
Prima di me l’unico che aveva fatto qualcosa sulle periferie era Salvatore Piscicelli: memorabile Le occasioni di Rosa (film del 1981, presentato al Festival del cinema di Venezia e per cui l’esordiente Marina Suma vinse il David di Donatello, in cui il sottoproletariato è protagonista della vicenda ambientata a Secondigliano dopo il terremoto dell’Irpinia, nda). Io avevo frequentazioni e letture americane: volevo raccontare questa parte del mondo che è luogo dell’anima e parla di personaggi che puoi trovare a ogni latitudine. Si tratta di storie interessanti dal punto di vista antropologico; la periferia è solo una lettura più superficiale. Un Messico napoletano, tanto per dire, negli anni è stato adottato dalla Yale University come libro di testo nel dipartimento di Italianistica. Per la verità, manca un film che trent’anni fa non si fece per mia volontà.
Trent’anni è l’età della maturità: l’idea del film oggi potrebbe essere quanto mai attuale, no?
All’epoca non si fece perché non mi convinceva la sceneggiatura. Ma io sono convinto che il libro abbia una vita sua e che non devi farti fagocitare dal successo e dalla popolarità. Dio mi ha dato il dono della penna ma ho dovuto fare l’attore: mi usavano per quei ruoli un po’ così, per il mio aspetto. Io da grande avrei voluto fare lo scrittore; ma sappiamo che di scrittura non si campa. Le gratificazioni, per la verità, sono arrivate a iosa e la ristampa mi fa immensamente piacere. Così come sono onorato della chiosa di copertina di Paolo Sorrentino.
Ecco, torniamo al libro: l’ispirazione è tutta americana?
Nelle mie letture c’erano scrittori che si avventuravano nei meandri dell’America che non era stata ancora raccontata. In Italia abbiamo avuto Pier Vittorio Tondelli, ingiustamente dimenticato, che resta lo scrittore di innovazione per eccellenza degli anni Ottanta: ci ha regalato un nuovo sguardo sulle città. Non l’ho mai conosciuto ma ho letto tutta la sua opera: in un mondo in cui scrivono tutti, ricordiamoci che siamo privilegiati, abbiamo avuto i migliori scrittori. I Ragazzi di vita di Pasolini sono i miei ragazzi di periferia, con uno sguardo lucido, rabbioso. Bisogna essere onesti e dire che, a cento anni dalla nascita, tutti hanno ricordato Pasolini; ma si tratta di un ricordo strumentale: un visionario come lui avrebbe dovuto avere altri spazi.
Un Messico napoletano è un viaggio nella periferia che si compie per la prima volta quando sono ancora pochi quelli che parlano delle marginalità.
Io avevo il desiderio di raccontare la mia Napoli uniformandomi a personaggi che vedevo e immaginavo. Mi riferisco alla malavita, al dolore ma anche ai ragazzi con i loro sogni, con la bellezza e con il loro sguardo sulla bellezza. Sia chiaro: se la bellezza è anche cruda e amara va bene. Ci hanno subissato di cazzate e cose brutte in televisione, e ora la gente non è più abituata…
Pensa a Gomorra?
Mi spiace per Roberto ma credo si sia lasciato prendere la mano dalla spettacolarizzazione. Napoli dopo Gomorra è cambiata ed è diventata stilizzata sull’effetto gomorra, appunto: abbigliamento, facce, iconografie, comportamenti… Non è un bene per una città che avrebbe dovuto evolversi. Va bene parlare dei ghetti ma non è che poi tutta la città diventa un ghetto. Invece è venuta fuori una cosa spiazzante. Si è legittimato un degrado di valori e subito dopo è arrivata una inflazione neomelodica. Significa che Napoli è stata svenduta per meri scopi commerciali.
Una strana operazione di marketing territoriale…
Oggi a Napoli arrivano i turisti ma sono quelli che fanno mordi e fuggi, non è il turismo che può avere una metropoli. Il punto è che Napoli è una città che ha sempre fame però si accontenta del panino con la mortadella.
E i giovani di oggi? Quanto sono diversi da quelli che lei raccontava trenta anni fa?
I giovani da quando li ho raccontato io hanno subito vessazioni e violenze, si sono dovuti adattare a un non mondo, a un non luogo, a non esistere. Oggi c’è un desiderio di narcotizzazione voluto dall’altro: penso al mondo dei social e ad altro. Avevamo promesso di essere chissà cosa e invece siamo alla fame. Anche con il Covid, ci hanno inculcato il virus della paura. Oggi i giovani di 24/25 anni o entrano nelle farmacie per acquistare chissà cosa o si fanno di popper (la droga dello sballo, nda). Su uno che ce la fa, altri novantanove soccombono. Io vivo tra di loro e ho la sensazione che la gioventù metropolitana sia vista come un fastidio dal potere. Quelli della mia generazione sono cresciuti con i partiti, con la chiesa, con le associazioni, con la lotta, con il sogno di cambiare il mondo; oggi non è più così.
“Ridateci i sogni”: ma perché sono scomparsi?
Sono stati cancellati in nome della potenza del denaro e del consumismo sfrenato. Ma ci rendiamo conto che oggi parliamo ancora di guerre? Sessant’anni fa Bob Dylan cantava contro le guerre e noi siamo ancora in guerra. A me, che sono un pensatore, tutto questo fa tanto male. Sa qual è il problema? Non ti danno neanche lo spazio per parlare. Quando cerchi di far prendere coscienza ai giovani ti tarpano le ali.
Un quadro tutt’altro che incoraggiante… Come si può uscire da questa impasse?
Io sono solo un pazzo visionario, non un politologo né un sociologo. Pensi che io me ne andai dalla banca dopo essere stato assunto da giovane perché avevo capito una cosa: volevo essere un uomo libero. Oggi, se non ti fai mettere i piedi in testa, in qualche modo risolvi. Il gioco del potere è proprio dominare, creare un branco: se hai il coraggio di uscire ti fanno male. L’Italia dovrebbe capire che è necessario investire sul futuro più che inviare armi all’Ucraina: è un controsenso illogico per un Paese che cade a pezzi, soprattutto per l’area popolare. Il problema è che in trent’anni non c’è stato un avanzamento rispetto alla questione etica e morale. A Napoli, come contentino, hanno dato l’università a Scampia.
Cambia poco…
Pensiamo per un attimo alla festa scudetto che abbiamo visto in lungo e in largo: non sono emozioni surrogate? Come se ci fosse stata una voglia esagerata di far vedere che si festeggia… Improvvisamente tutti sono diventati tifosi. Il pallone diventa un’arma per far sentire viva la gente. E tutti si piegano al volere generale. Ma forse Napoli serviva anche in questo: spesso tirano fuori questa città come salva-nazione. Sia chiaro: io non sono il capopopolo o il Masaniello di turno; io vorrei fare quello che è richiesto agli artisti: segnalare, evidenziare alcune cose.
Quanto è difficile farlo a Napoli e nel nostro Paese in generale?
Ho subito spesso ostracismo ma credo che per un uomo-artista la cosa fondamentale sia non tradire la propria coscienza. Ci deve essere rispetto per te e per quello che hai fatto.